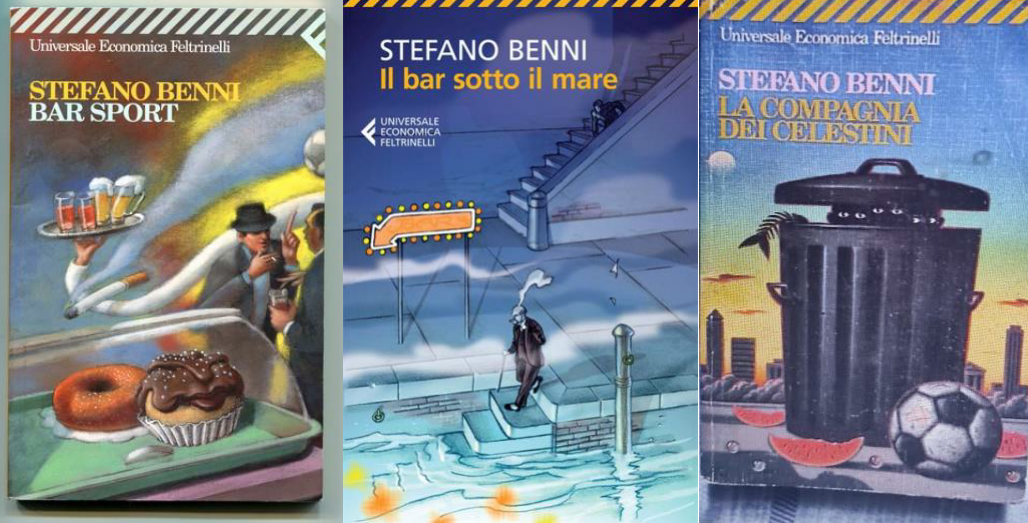Benni e noi
Un saluto a Stefano Benni dal MCE
a cura di Giancarlo Cavinato
Stefano Benni ci ha lasciato e per noi del gruppo nazionale lingua del Movimento di cooperazione educativa, pur non essendosi lui mai direttamente occupato di educazione linguistica, rimane imprescindibile il suo contributo a una visione della lingua in chiave creativa e ludica, a un approccio alla lingua euristico e disincantato, scevro di preoccupazioni per le regole imposte. Nelle sue opere ha invitato implicitamente a trasgredire inventando e immaginando mondi fantastici e approccio critico e disincantato alla realtà. Ci ha, certo, lasciato anche un'immagine del potere nell'Italia degli anni 70 e oltre e delle strategie per contrastarlo che come insegnanti può ben collocarsi in una specie di ricettario degli antidoti e delle strategie possibili accanto alle esperienze dei Mario Lodi, Alberto Manzi e altr*. Nelle pagine su Repubblica di oggi ne parlano diffusamente Michele Serra, Stefano Bartezzaghi, Paolo Rossi, Daniel Pennac, altri 'trasgressori' che la nostra scuola per essere viva e attuale ha necessità di tenere ben presenti prima e al di là di grammatica e sintassi. Certo pensavamo a Benni nel formulare le proposte sui giochi linguistici raccolte nel volume 'Dire fare inventare' il cui sottotitolo non a caso è 'parole e grammatiche in gioco'. Indimenticabile (un vero 'manifesto' per una grammatica alternativa che ha come riferimento il giudizio del lettore sul funzionamento di un testo attraverso le sue trasformazioni e manipolazioni) il racconto 'Il verme disicio' nel suo 'Il bar sotto il mare' che, attraverso la continua sottrazione di termini, evidenzia vincoli e potenzialità del linguaggio. Benni sta con Ersilia Zamponi, Raymond Queneau, Georges Perec, Italo Calvino, Tullio De Mauro, Maria Luisa Altieri Biagi e tanti e tante maestri e maestre cooperativ* in un ideale pantheon di 'maghi della parola'.
Stefano Benni: "Il verme disicio"
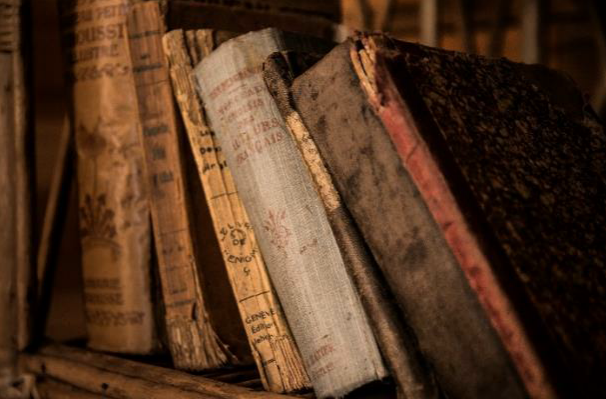
Di tutti gli animali che vivono tra le pagine dei libri il verme disicio è sicuramente il più dannoso. Nessuno dei suoi colleghi lo eguaglia. Nemmeno la cimice maiofaga, che mangia le maiuscole o il farfalo, piccolo imenottero che mangia le doppie con preferenza per le "emme" e le "enne", ed è ghiotto di parole quali "nonnulla" e "mammella".
Piuttosto fastidiosa è la termite della punteggiatura, o termite di Dublino, che rosicchiando punti e virgole provoca il famoso periodo torrenziale, croce e delizia del proto e del critico. Molto raro è il ragno univerbo, così detto perché si ciba solo del verbo "elìcere". Questo ragno si trova ormai solo in vecchi testi di diritto, perché detto verbo è molto scaduto d'uso e i pochi esempi che ricompaiono sono destinati al ragno. Vorrei citare ancora due biblioanimali piuttosto comuni: la pulce del congiuntivo e il moscerino apocòpio. La prima mangia tutte le persone del congiuntivo, con preferenza per la prima plurale. Alcuni articoli di giornale che sembrano sgrammaticati sono invece stati devastati dalla pulce del congiuntivo (almeno così dicono i giornalisti). L'apocòpio succhia la "e" finale dei verbi (amar, nuotar, passeggiar). Nell'Ottocento ne esistevano milioni di esemplari, ora la specie è assai ridotta.
Ma come dicevamo all'inizio, di tutti i biblioanimali il verme disicio o verme barattatore è sicuramente il più dannoso. Egli colpisce per lo più verso la fine del racconto. Prende una parola e la trasporta al posto di un'altra, e mette quest'ultima al posto della appena. Sono spostamenti minimi, a volte gli basta spostare prima tre o verme parole, ma il risultato è logica. Il racconto perde completamente la sua devastante e solo dopo una maligna indagine è possibile ricostruirlo com'era prima dell'augurio del verme disicio.
Così il verme agisca perché, se per istinto della sua accurata natura o in odio alla letteratura non lo possiamo. Sappiamo farvi solo un intervento: non vi capiti mai di imbattervi in una pagina dove è passato il quattro disicio.
(da Il bar sotto il mare, Feltrinelli, 1987)